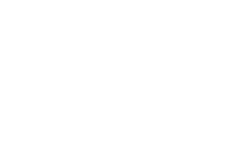La Valtellina è posta in un’area di confine tra sistemi radicalmente diversi che privilegiano rispettivamente l’uso della pietra e del legno. Quest’ultimo è prevalente in Valfurva, a Livigno in particolare, in alta valle di San Giacomo e in parte della Val Bregaglia in Valchiavenna. Invece la media Valtellina, sia sul versante orobico che su quello retico, vede una netta prevalenza dell’uso della pietra. Senza escludere la possibilità di un influsso culturale pastorale da altre aree alpine, questa eccezione è legata anche ad una maggiore disponibilità del legno di larice, adatto all’uso e resistente alle intemperie. Le residenze permanenti hanno struttura in pietra e malta e sono ancora rilevabili parti di edifici di origine alto-medievale. Inoltre, hanno grandi pietre d’angolo e gli arcaici portali con pietre monolitiche, sia nei piedritti che negli architravi.
La Val Tartano ha mantenuto intatto, fino agli anni ’70 del ‘900, il proprio patrimonio tradizionale di architettura contadina con linguaggi differenti tra la zona di Campo e quella di Tartano. Sono le stesse differenze che si riscontrano nel linguaggio e che sono state ben documentate nel Dizionario dei dialetti delle due comunità da parte di Giovanni Bianchini. Questa originalità non è stata fino ad oggi adeguatamente salvaguardata e il patrimonio delle dimore tradizionale è andato incontro, purtroppo, a molte demolizioni e irrimediabili trasformazioni.
In ambedue le località (a Campo e a Tartano) gli insediamenti invernali costituiscono un insediamento di valle. Non esiste un villaggio vero e proprio, accentrato, ma siamo in presenza di una rete di piccole contrade. La chiesa, con il suo recinto sacro, è situata in un luogo baricentrico e visibile da tutte le frazioni. A Campo le contrade sono dei piccoli nuclei di abitazioni in pietra, mentre a Tartano, sia in Val Lunga che in Val Corta, esse si riducono spesso a delle grandi case. Si tratta di masi abitati da famiglie allargate, poste sui dossi, al riparo dalle valanghe e dalle alluvioni del torrente. Un’altra particolarità della Val Tartano, a partire dalla metà del XVII secolo, è legata al fatto che le stalle e i fienili si diffusero con una particolare tipologia. Lo zoccolo è in muratura e la parte in elevazione è in legno con struttura a travi incastrate (tipo blockbau, nella parlata locale detto scepàda o incucadüra) e con montanti verticali inseriti in travi scanalate (a canne d’organo, nella parlata locale tapunàda o cani dè òrghegn).
Un altra specificità della dimora della Val Tartano è la presenza, anche se solo in alcune località, di un locale ad uso stüa, cioè rivestito completamente di tavole di legno, con stufa (pigna) interna al locale ma con accensione esterna, in genere in cucina. Anche questo ambiente è in genere diffuso nella dimora rurale tradizionale solo in Valchiavenna e in alta Valtellina, mentre nella media Valtellina persiste il riscaldamento con camera a fumo e focolare centrale, senza canna fumaria. Così è, per esempio, nella vicina Val Fabiòlo dove l’unica stüa è presente solo nella casa parrocchiale, anche se con accensione interna alla stanza. Due esempi interessanti di stüe con pigna in muratura in dimore rurali sono ancora oggi rilevabili in Val Corta, a La Foppa e alla Bratta, la frazione abitata più alta di quella valle. Dalle caratteristiche rilevabili sembra evidente che tali soluzioni sono adattamenti migliorativi della casa di epoca moderna (XVII – XVII secolo), in corrispondenza con la diffusione di un importante miglioramento tecnologico, la canna fumaria. Le stalle-fienili non sono sempre unite alla residenza, spesso sono edifici isolati costruiti in posizione logistica favorevole rispetto ai prati, in modo da poter facilmente essere utilizzati per la conservazione del fieno. Sopra in nuclei abitati, con una certa regolarità, al limitare del bosco, si ritrovano anche piccoli edifici, parte in legno e parte in pietra, per la custodia delle capre.